25/06/2018
Pubblicato da Politica in Penisola il 25/06/2018
Abbiamo il piacere di pubblicare in anteprima per i nostri lettori la presentazione scritta da Fabrizio d’Esposito, inviato de “Il Fatto Quotidiano”, per il nuovo libro di Raffaele Lauro, in uscita in formato digitale, che raccoglie tutti gli interventi dell’autore, ospitati settimanalmente su questo blog, come diario politico, pre e post elezioni del 4 marzo 2018. La presentazione del nostro autorevole conterraneo e amico, Fabrizio, rappresenta un lucido e rigoroso saggio sull’attuale situazione politica italiana e sul futuro del nostro paese.
di Fabrizio d’Esposito
“Era il 31 gennaio scorso, di mercoledì, quando ho avuto il privilegio di condividere con Raffaele Lauro la nascita di questo suo lungo diario, dapprima elettorale e poi alle prese con gli Ottantanove (numero evocativo dal punto di vista rivoluzionario) giorni di una crisi repubblicana mai vissuta per prassi e metodo seguiti. E sin dall’inizio, nelle riflessioni di Lauro, si scorgeva la cupa immagine di un baratro nazionale. Già allora, infatti, erano manifesti gli indizi di uno scenario drammatico e incerto provocato da una grave crisi di sistema. Senza dimenticare che proprio in quella fase si erano chiuse le liste elettorali e sia il Pd sia Forza Italia avevano optato per un’ottusa difesa conservatrice e perdente del loro status, anziché aprirsi, con idee e interpreti nuovi, alla sfida contro le forze populiste pronosticate come vincitrici: in primis il Movimento 5 Stelle, non più l’apriscatole di Grillo e Casaleggio senior, bensì il contenitore post-ideologico e governista di Luigi Di Maio; ma anche la Lega risorta di Matteo Salvini, con l’ambizioso obiettivo di smettere gli antichi panni del partito regionalista e di indossare l’elmo di Scipio sull’intero territorio italico.
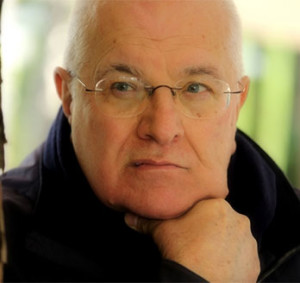
Questo dunque il punto di partenza del diario di Lauro, cui mi preme aggiungere una nota personale prima di addentrarmi nel merito delle ampie questioni trattate delle sue considerazioni, destinate alla fine a formare un corpus narrativo di notevole spessore. Quella di Lauro è la biografia di un grande servitore dello Stato, con numerosi incarichi di altissimo profilo istituzionale, ma che ha il centro in una cultura politica oggi diventata una merce rara. In tempi digitali rozzi e superficiali (altro tema di questo diario), il Professore – per usare il termine con il quale Lauro è appellato da decenni nella nostra natìa costiera sorrentina – dimostra di essere uno studioso formidabile dallo sguardo largo, che include storia e filosofia, economia e padronanza dei new media. Ed è per questo che le sue pagine, in oltre quattro mesi, a partire dal primo febbraio, il giorno in cui il diario inizia, hanno impreziosito il mio lavoro di giornalista. Impegnato a decifrare quotidianamente i tatticismi di leader e colonnelli, ho ritrovato in Lauro il piacere e la curiosità di raffrontarmi con una visione decisamente più completa, densa di spunti e intuizioni figlie di quella cultura politica di Lauro. E qui s’innesta un’altra riflessione. Ché pur avendo avuto idee diverse dal Professore, entrambi siamo accomunati dalla passione per una dialettica rigorosa e non improvvisata, per un confronto in cui si può essere avversari ma non nemici. Non solo. Proprio in virtù di questa comune appartenenza ideale, ma non ideologica (Lauro è di centro, io di sinistra), accogliamo il nuovo tempo del populismo con scetticismo e timori, rimpiangendo il Novecento dei partiti pesanti, macchine sì piene di difetti e storture, ma comunque in grado di assicurare una selezione della classe dirigente e una costante mediazione tra Palazzo e territorio.
 Nostalgia della Prima Repubblica? Sì, fino a un certo punto però. Ché adesso è il momento di affrontare le questioni del diario e comincio da uno dei sintomi iniziali segnalati da Lauro sulla “patologia degenerativa della politica italiana”. Ossia l’astensionismo, aggravato dall’oscurantismo medievale che ha segnato la formazione delle liste dei partiti tradizionali della Seconda Repubblica, Forza Italia e Pd, protagonisti di un tracollo micidiale il 4 marzo scorso: le due forze rappresentano poco più del 30 per cento dell’elettorato dopo aver governato (anche insieme) il Paese per dieci anni, contando le elezioni politiche del 2008 e quelle successive del 2013.
Nostalgia della Prima Repubblica? Sì, fino a un certo punto però. Ché adesso è il momento di affrontare le questioni del diario e comincio da uno dei sintomi iniziali segnalati da Lauro sulla “patologia degenerativa della politica italiana”. Ossia l’astensionismo, aggravato dall’oscurantismo medievale che ha segnato la formazione delle liste dei partiti tradizionali della Seconda Repubblica, Forza Italia e Pd, protagonisti di un tracollo micidiale il 4 marzo scorso: le due forze rappresentano poco più del 30 per cento dell’elettorato dopo aver governato (anche insieme) il Paese per dieci anni, contando le elezioni politiche del 2008 e quelle successive del 2013.  Il risultato di questo decennio finale della Seconda Repubblica è stato crudele: per la prima volta nel cuore dell’Europa occidentale è nato un governo che non appartiene alle famiglie tradizionali continentali, quella popolare (gli ex democristiani che hanno accolto gli azzurri dell’ex Cavaliere pregiudicato) e quella socialista (che ingloba il Pd). Non a caso, nel suo diario, Lauro parla di “sconfitte reali” a fronte delle “vittorie apparenti” di M5S e Lega. Ma fermiamoci alle “sconfitte reali” di Matteo Renzi e Silvio Berlusconi, giusto per fare nomi e cognomi. Il loro disastro combinato con il 27,1 per cento di astensionismo è la spia della peggiore crisi di sistema dell’era repubblicana. Le elezioni del 4 marzo, come accennato prima, hanno registrato la più bassa percentuale di affluenza in settant’anni di democrazia parlamentare. Un dato che risalta ancora di più se si pensa che noi italiani siamo stati per decenni i campioni europei di partecipazione alle urne, con una media costante di votanti ben oltre l’ottanta per cento (il picco fu il 93,8 alle elezioni politiche del 1953). Oggi invece siamo diventati un Paese di elettori stanchi, sfiduciati e arrabbiati. Come siamo arrivati a questo punto?
Il risultato di questo decennio finale della Seconda Repubblica è stato crudele: per la prima volta nel cuore dell’Europa occidentale è nato un governo che non appartiene alle famiglie tradizionali continentali, quella popolare (gli ex democristiani che hanno accolto gli azzurri dell’ex Cavaliere pregiudicato) e quella socialista (che ingloba il Pd). Non a caso, nel suo diario, Lauro parla di “sconfitte reali” a fronte delle “vittorie apparenti” di M5S e Lega. Ma fermiamoci alle “sconfitte reali” di Matteo Renzi e Silvio Berlusconi, giusto per fare nomi e cognomi. Il loro disastro combinato con il 27,1 per cento di astensionismo è la spia della peggiore crisi di sistema dell’era repubblicana. Le elezioni del 4 marzo, come accennato prima, hanno registrato la più bassa percentuale di affluenza in settant’anni di democrazia parlamentare. Un dato che risalta ancora di più se si pensa che noi italiani siamo stati per decenni i campioni europei di partecipazione alle urne, con una media costante di votanti ben oltre l’ottanta per cento (il picco fu il 93,8 alle elezioni politiche del 1953). Oggi invece siamo diventati un Paese di elettori stanchi, sfiduciati e arrabbiati. Come siamo arrivati a questo punto?
A questo punto s’incrocia nuovamente la parziale nostalgia per il sistema dei partiti pesanti e ideologici della Prima Repubblica. Parziale e non completa perché quel bipartitismo bloccato, da un lato la Dc e dall’altro il Pci, davanti alla devastazione della corruzione dilagante e del conseguente finanziamento illecito della partitocrazia, per usare il termine caro a Pannella buonanima, fu letteralmente incapace di una riforma profonda del sistema istituzionale e politico. Ecco il punto che poi è tornato in auge alla vigilia delle elezioni politiche del 2018: l’incapacità della classe dirigente al potere di autoriformarsi. E’ un tratto questo che apre e chiude due cicli: quello lunghissimo tra il 1948 e il 1993 e quello del ventennio cosiddetto breve della Seconda Repubblica, dal 1994 al 2018. Un quarto di secolo fa il sistema esplose per le inchieste dei magistrati sulla corruzione e sulla collusione con le mafie italiane (da lì il fenomeno del giustizialismo); quest’anno a causa del sentimento anti-casta interpretato dal populismo post-ideologico dei grillini e dal sovranismo razzista e di estrema destra della Lega di Matteo Salvini. Mi soffermo volutamente su questo aspetto per due motivi.
 Il primo riguarda la questione morale, che lo stesso Lauro cita nel diario del 2 marzo quando ricorda un suo libro in merito del 1991. Senza dimenticare che in quell’anno il Professore era il motore della principale componente della Dc, la famosa corrente del Golfo: da intellettuale al fianco di due delle personalità più note dei neodorotei, Antonio Gava e Vincenzo Scotti, Lauro ebbe la percezione della quasi irreversibilità dei guasti del sistema. Il compito dello studioso che si sporca le mani con la politica è proprio questo: vedere il problema in anticipo e tentare di dare soluzioni. Invano, in questo caso. Il sistema precipitò e arrivò l’antipolitica col volto sorridente e guascone di Silvio Berlusconi, già piduista e imprenditore vicinissimo al Psi di Bettino Craxi. A sua volta, dopo 25 anni, l’ex Cavaliere è diventato il “vecchio” da abbattere insieme a Renzi, suo figlioccio spregiudicato e vero erede politico. E’ il contrappasso dantesco che tocca a chi si accontenta di lucrare sui due mali atavici della politica italiana, e che per certi versi non risparmiarono neanche il regime fascista di Mussolini: l’inerzia e la gestione del potere fine a se stessa. Stalin la chiamava la malattia del poterismo.
Il primo riguarda la questione morale, che lo stesso Lauro cita nel diario del 2 marzo quando ricorda un suo libro in merito del 1991. Senza dimenticare che in quell’anno il Professore era il motore della principale componente della Dc, la famosa corrente del Golfo: da intellettuale al fianco di due delle personalità più note dei neodorotei, Antonio Gava e Vincenzo Scotti, Lauro ebbe la percezione della quasi irreversibilità dei guasti del sistema. Il compito dello studioso che si sporca le mani con la politica è proprio questo: vedere il problema in anticipo e tentare di dare soluzioni. Invano, in questo caso. Il sistema precipitò e arrivò l’antipolitica col volto sorridente e guascone di Silvio Berlusconi, già piduista e imprenditore vicinissimo al Psi di Bettino Craxi. A sua volta, dopo 25 anni, l’ex Cavaliere è diventato il “vecchio” da abbattere insieme a Renzi, suo figlioccio spregiudicato e vero erede politico. E’ il contrappasso dantesco che tocca a chi si accontenta di lucrare sui due mali atavici della politica italiana, e che per certi versi non risparmiarono neanche il regime fascista di Mussolini: l’inerzia e la gestione del potere fine a se stessa. Stalin la chiamava la malattia del poterismo.
 Il secondo motivo riguarda il continuo riferimento di Lauro alla situazione economica e finanziaria del nostro Paese. A partire ovviamente dalla montagna enorme, una sorta di Everest di danaro, del debito pubblico: 2.300 miliardi di euro. Oggi questa montagna si frappone tra il realismo prudente del ministro tecnico dell’Economia, Tria, e il libro dei sogni grilloleghista. Sullo sfondo la matrigna cattiva e tecnocratica dell’Unione europea a trazione teutonica. Ma quel debito è un altro dei frutti avvelenati della patologia degenerativa del sistema che ha provocato l’esecutivo populista e sovranista.
Il secondo motivo riguarda il continuo riferimento di Lauro alla situazione economica e finanziaria del nostro Paese. A partire ovviamente dalla montagna enorme, una sorta di Everest di danaro, del debito pubblico: 2.300 miliardi di euro. Oggi questa montagna si frappone tra il realismo prudente del ministro tecnico dell’Economia, Tria, e il libro dei sogni grilloleghista. Sullo sfondo la matrigna cattiva e tecnocratica dell’Unione europea a trazione teutonica. Ma quel debito è un altro dei frutti avvelenati della patologia degenerativa del sistema che ha provocato l’esecutivo populista e sovranista.
I quasi due decenni del nuovo millennio hanno fatto aumentare questa montagna e a un certo punto, nel 2011, l’allora capo dello Stato Giorgio Napolitano impose ai partiti e al Paese il governo tecnico di Mario Monti. Lacrime, sangue, sacrifici: altra benzina per la spinta propulsiva del neoqualunquismo. Da quel momento è come se fossimo entrati nel tunnel finale del circolo vizioso imboccato con il malato incurabile del debito pubblico. Immaginare una via d’uscita razionale in questi tempi folli e di cambiamento, come usa dire, è molto difficile. I pifferai magici imperversano e sovviene solo il pessimismo della ragione di Gramsci, ripreso negli anni ottanta da Ugo La Malfa.
 Nel suo diario, Lauro tra i fondamenti del nuovo Medioevo politico italiano pone giustamente il famigerato Rosatellum, dal nome del deputato democratico cui è intestata l’orrenda legge elettorale che mette insieme, in maniera innaturale e dolosa, il 64 per cento di proporzionale e il 36 per cento di maggioritario. Anche il Rosatellum rientra nella patologia degenerativa fin qui illustrata. Ché la legge elettorale è stato il mezzo con cui Renzi e Berlusconi si sono illusi di fermare la deriva populista e perpetuare il renzusconismo mai sopito del patto del Nazareno. Miopi e senza alcun senso della realtà, credevano di portare al 40 per cento i gemelli diversi Pd e Forza Italia e scamparla per un’altra legislatura, mettendo nell’angolo i Cinquestelle, terzo lato del tripolarismo asimmetrico della vigilia. Ancora una volta una soluzione di cortissimo respiro anziché sciogliere i nodi strutturali della crisi dei loro partiti. Sottovalutazione e basta? No, forse anche impotenza.
Nel suo diario, Lauro tra i fondamenti del nuovo Medioevo politico italiano pone giustamente il famigerato Rosatellum, dal nome del deputato democratico cui è intestata l’orrenda legge elettorale che mette insieme, in maniera innaturale e dolosa, il 64 per cento di proporzionale e il 36 per cento di maggioritario. Anche il Rosatellum rientra nella patologia degenerativa fin qui illustrata. Ché la legge elettorale è stato il mezzo con cui Renzi e Berlusconi si sono illusi di fermare la deriva populista e perpetuare il renzusconismo mai sopito del patto del Nazareno. Miopi e senza alcun senso della realtà, credevano di portare al 40 per cento i gemelli diversi Pd e Forza Italia e scamparla per un’altra legislatura, mettendo nell’angolo i Cinquestelle, terzo lato del tripolarismo asimmetrico della vigilia. Ancora una volta una soluzione di cortissimo respiro anziché sciogliere i nodi strutturali della crisi dei loro partiti. Sottovalutazione e basta? No, forse anche impotenza.  Vale soprattutto per Renzi. L’ex bambino che si mangiò i comunisti del Pd era reduce da una sequenza incredibile di sconfitte: regionali e amministrative del 2015, ancora amministrative del 2016, referendum del 2016. Per lui quindi il voto del 4 marzo rappresentava innanzitutto la sopravvivenza delle sue ambizioni personali e del cerchio magico che lo ha coadiuvato negli anni di Palazzo Chigi. Idem Berlusconi: il leader più anziano di tutti è partito lunghissimo nella campagna elettorale ed è giunto stremato al voto, già conscio di vivere il dramma del secondo posto nel centrodestra, dietro la Lega. Una cicatrice di difficile rimarginazione per l’ego e per il carisma dell’Ottuagenario.
Vale soprattutto per Renzi. L’ex bambino che si mangiò i comunisti del Pd era reduce da una sequenza incredibile di sconfitte: regionali e amministrative del 2015, ancora amministrative del 2016, referendum del 2016. Per lui quindi il voto del 4 marzo rappresentava innanzitutto la sopravvivenza delle sue ambizioni personali e del cerchio magico che lo ha coadiuvato negli anni di Palazzo Chigi. Idem Berlusconi: il leader più anziano di tutti è partito lunghissimo nella campagna elettorale ed è giunto stremato al voto, già conscio di vivere il dramma del secondo posto nel centrodestra, dietro la Lega. Una cicatrice di difficile rimarginazione per l’ego e per il carisma dell’Ottuagenario.

Nel bene e nel male, il voto del 4 marzo è la terza faglia politica in settant’anni di Repubblica. A differenza della Francia, dove la numerazione repubblicana è dovuta ai cambi costituzionali, noi italiani ci limitiamo a indicare impropriamente come Prima e Seconda Repubblica due diverse ere politiche a Carta immutata o quasi. E adesso la Terza. Che cos’è la Terza Repubblica? Nel suo denso diario, ricco di felici comparazioni letterarie e storiche, Lauro ci regala una lezione da tenere a mente nei futuri mesi: quella sui partiti hotchpotch, basati su un miscuglio confuso di cose diverse. E’ la prevalenza del pragmatismo dopo la caduta delle ideologie. Il Professore, acutamente, gli assegna un solo colore: il grigio. Un grigio che copre anche la coalizione gialloverde o gialloblu del premier Conte. L’intuizione di Lauro stimola varie riflessioni su questa nuova terra incognita. La prima è che la mancanza di valori caratterizzanti implica una sempre maggiore volatilità del voto. Cioè una minore fedeltà rispetto al passato. L’elettore di volta in volta decide il prodotto da scegliere nelle urne, per dirla in termini commerciali. Questa inedita volatilità, quasi incredibile per un Paese congelato per decenni in due blocchi, uno democristiano e l’altro comunista, rischia di rendere sempre più breve la durata dei cicli repubblicani.

Mi spiego con un esempio narrativo: nei thriller spesso c’è un serial killer che colpisce dapprima a distanza di anni, poi di mesi, infine di settimane e giorni. Gli omicidi aumentano col peggioramento della condizione mentale dell’assassino, ovviamente uno psicopatico. Nel nostro caso, il serial killer è l’elettore. Dopo la fine della Prima Repubblica, il credito concesso a Silvio Berlusconi è stato relativamente alto, un quarto di secolo, ma con Renzi è durato neanche un lustro. Insomma, di anno in anno le urne accorciano sempre più le parabole politiche dei leader emersi sulla scena nazionale. Accadrà anche con Salvini e Di Maio? E’ probabile ma non certo. Ché soprattutto con il duce leghista c’è da tenere presente un fattore radicato della società italiana. Pur immersi nella sbornia anti-sistema del populismo post-ideologico, non dimentichiamo che l’Italia è un Paese tendenzialmente di destra. Purtroppo. Colpisce, in merito, l’analogia se non la simmetria tra le due vie d’uscita delle crisi del 1994 e del 4 marzo. Ventiquattro anni fa sembrava scontata la vittoria dei Progressisti di Achille Occhetto: invece la sinistra superstite della Prima Repubblica non fu che lo sgabello involontario, meglio il predellino, per il lancio in paradiso della stella berlusconiana. Stessa storia quest’anno: Di Maio era il favorito per Palazzo Chigi eppure Matteo Salvini, con la metà o quasi dei voti grillini, si è imposto come il nuovo padrone della politica italiana. Berlusconi e Salvini, due modi di interpretare la destra in un Paese che ha conosciuto l’immane tragedia del fascismo. Non c’è da stare tranquilli riandando a quello che scrive Lauro nel diario del 9 febbraio sul clima della campagna elettorale, tra odio sociale e deriva autoritaria.

La volatilità dell’elettore modello serial killer ha un truculento effetto collaterale su cui Lauro si è soffermato a lungo: il cannibalismo della Terza Repubblica nascente. E il candidato migliore a fare l’Hannibal Lecter del potere italiano è senza dubbio Matteo Salvini, professionista della politica nonché purosangue della campagna elettorale permanente. Il leader della Lega blu e lepenista ha innanzitutto due forni per continuare la sua luna di miele con l’elettorato: capo di un nuovo centrodestra, mangiandosi quel che resta di Forza Italia, oppure futuro condottiero di una coalizione gialloverde o gialloblu con i pentastellati in posizione subalterna. Determinante sarà capire cosa succederà alle elezioni europee del 2019, ma nel frattempo è già chiaro il pericolo che corre il M5S governista di Luigi Di Maio. Nella sua ansia di cambiamento – dettata anche da equilibri interni perché i grillini hanno la mannaia dei due mandati che limitano leadership solide e durature – il movimento populista sta già scontando le sue debolezze: l’incapacità di saper fare politica; la mancanza di una classe dirigente adeguata (eclatanti i casi dei consulenti Marra e Lanzalone nella Roma di Virginia Raggi); l’inclinazione moderata e andreottiana del suo attuale capo azzimato e incravattato in tutte le ore del giorno, il vicepremier Di Maio. Il giovanotto di Pomigliano con la sua strategia inclusiva, tipica di ogni establishment, ha connotato il M5S come una sorta di Dc del populismo, per usare una indovinata definizione di Marco Revelli. Di conseguenza l’attuale governo può anche essere il centrodestra del futuro, con la Lega a fare la destra e il M5S il centro. Ma per quanto tempo? Il dubbio è questo.

A proposito di democristiani e democristianeria. Nella seconda parte del diario, quella dedicata alla crisi degli Ottantanove giorni per arrivare alla formazione del governo Conte, Lauro non manca di lodare l’antica sapienza di un cattolico democratico come Sergio Mattarella. Il capo dello Stato ha gestito un’inedita crisi di sistema senza mai allontanarsi di un centimetro dalla prassi costituzionale, a differenza del suo predecessore interventista e postcomunista. Il metodo di Mattarella è stato comunque innovativo, in linea con il ruolo di arbitro che l’ex ministro della sinistra dc si è dato al momento della sua elezione al Quirinale, nel 2015. Il presidente della Repubblica si è servito della maieutica socratica per estrarre l’unica soluzione possibile dallo schema ingessato dei risultati del 4 marzo. Il metodo della levatrice per un parto estenuante, frenato dai machiavellismi di Salvini e dall’infantilismo monotematico di Di Maio (“Voglio fare il premier, voglio fare il premier” e null’altro) nonché dal nullismo del bullo di Rignano, con tanto di popcorn per assistere allo spettacolo dei vincitori apparenti. Tra consultazioni ed esplorazioni, minacce di voto anticipato e l’incarico tattico a Carlo Cottarelli, Mattarella è andato avanti per la sua strada evitando al Paese un nuovo trauma elettorale.

Ma è il caso di Paolo Savona, l’euroscettico che Salvini voleva ministro dell’Economia, che dà la cifra della tenuta del Quirinale nei tre mesi che vanno da 4 marzo al primo giugno, giorno del varo del nuovo governo. Il capo dello Stato aveva già avvisato i due vincitori apparenti con un importante discorso tenuto a Dogliani, in Piemonte, in occasione dell’anniversario del giuramento di Luigi Einaudi da capo dello Stato: in base all’articolo 92 della Costituzione è il presidente della Repubblica che nomina i ministri. Il sottotesto era chiaro e rimandava alla tradizione della prassi costituzionale che spesso ha visto “cambiare” alcune caselle del governo nello Studio alla Vetrata del Quirinale, quando il premier incaricato sottopone al capo dello Stato le proposte per i ministri. Volutamente, invece, Salvini, con al traino Di Maio, ha cercato e ottenuto lo scontro su Savona, autore di un libro in cui teorizza l’uscita dall’euro dalla notte alla mattina, per far fallire il primo tentativo di Conte. E dopo aver tirato il macigno ha nascosto pure la mano ché è stato poi Di Maio a chiedere grottescamente la messa in stato d’accusa del Quirinale. Mattarella avrebbe potuto innescare un’ulteriore crisi gravissima delle istituzioni ma da gentiluomo siciliano e custode dell’esito elettorale del 4 marzo ha incredibilmente dato altro tempo a M5S e Lega per conseguire l’obiettivo del governo.
L’immagine di Carlo Cottarelli, tecnico incaricato, che va al Quirinale per la lista dei ministri e poi va via da un’uscita secondaria è un memorabile colpo di scena degli Ottantanove giorni. Tutto ciò da anche la misura della solitudine del Colle in questo stallo infinito: a differenza di Giorgio Napolitano, per esempio, Mattarella non ha potuto contare sul suo partito di riferimento (il Pd) da usare come baricentro per la formazione del governo. I costituzionalisti hanno materiale in abbondanza per i loro studi sulle innovazioni della prassi apportate da questa crisi: il ribaltamento della Carta operato con il primato del programma (il contratto di governo) sulla figura del presidente del Consiglio; le esplorazioni con perimetro delimitato dei presidenti del Parlamento; la moral suasion sul populista buono, Di Maio, distinto da quello cattivo, Salvini; l’ostruzionismo al capo dello Stato da parte del partito che lo ha scelto e proposto per l’elezione al Colle, il Pd renziano; il controverso caso Savona.
Le mie considerazioni sul diario di Raffaele Lauro volgono al termine e non posso eludere la sfida lanciata dal titolo: “L’Italia sul baratro”. Il pericolo è quello di cambiare la preposizione. Nel al posto di sul. L’Italia nel baratro. Ché tutto quello che ricavo dalla lettura del libro del Professore – e che ho tentato di sviluppare sinora dal mio punto di vista – mi riporta di nuovo al pessimismo della ragione citato prima. A maggior ragione dopo aver assistito alle prime settimane di Salvini ministro dell’Interno, autore di inaccettabili dichiarazioni per un posto cruciale e di garanzia come il Viminale. Il punto è che all’orizzonte non ci sono risposte alternative. Lauro scrive di “Nuova Resistenza”. In che modo, mi chiedo? Ho la sensazione che dopo un eventuale fallimento del governo Conte ci sarà una “cosa” altrettanto nuova. Certo non Renzi o Berlusconi. L’Italia è di fronte al dramma di una volatilità elettorale che può portarci in altri lidi ignoti. Per il momento a predominare è la figura del leader leghista, nuovo duce cannibale della politica. Sbaglia, secondo me, chi pensa che l’alternativa possa essere una forza moderata in senso macroniano. Ci vogliono risposte più radicali che riformiste per prosciugare le ragioni sociali che ingrassano il populismo e il sovranismo. Di sinistra, diciamolo pure. Sempre che non sia troppo tardi. Purtroppo il socialismo è uno spettro morente che si aggira per tutta Europa, certamente non il fantasma che aleggiava ai tempi di Marx.
*inviato de “Il Fatto Quotidiano”
Roma, 25 giugno 2018




 Gentile professoressa Delfina, in un momento di profonda tristezza e di distacco terreno, desidero farLe pervenire le mie più sincere condoglianze per la scomparsa del Suo adorato [..]
Gentile professoressa Delfina, in un momento di profonda tristezza e di distacco terreno, desidero farLe pervenire le mie più sincere condoglianze per la scomparsa del Suo adorato [..]  Caro Direttore, Ti prego di pubblicare, per i lettori della Penisola Sorrentina, questa “allarmante” intervista al professor Maurizio Fiasco, massimo esperto e studioso di livello [..]
Caro Direttore, Ti prego di pubblicare, per i lettori della Penisola Sorrentina, questa “allarmante” intervista al professor Maurizio Fiasco, massimo esperto e studioso di livello [..]  Domani 10 febbraio 2025, Raffaele Lauro, nato a Sorrento il 10 febbraio 1944, compie 81 anni. Anche se risiede dagli anni Ottanta del secolo scorso, a Roma, in ragione dei suoi incarichi pubblici e [..]
Domani 10 febbraio 2025, Raffaele Lauro, nato a Sorrento il 10 febbraio 1944, compie 81 anni. Anche se risiede dagli anni Ottanta del secolo scorso, a Roma, in ragione dei suoi incarichi pubblici e [..]  Il brand “Mauro Lorenzi Profumi”, in occasione del Santo Natale 2024 e del Capodanno 2025, ha il grande piacere di formulare i migliori auguri e, in particolare, i più sinceri [..]
Il brand “Mauro Lorenzi Profumi”, in occasione del Santo Natale 2024 e del Capodanno 2025, ha il grande piacere di formulare i migliori auguri e, in particolare, i più sinceri [..]  “La scomparsa del carissimo presidente Raffaele Russo mi riempie di grandissimo dolore per la profonda stima e per l’affetto fraterno, che ci hanno legato, in tanti anni di condivisione [..]
“La scomparsa del carissimo presidente Raffaele Russo mi riempie di grandissimo dolore per la profonda stima e per l’affetto fraterno, che ci hanno legato, in tanti anni di condivisione [..]